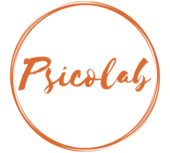“La cosa più difficile al mondo è pensare”.
Blaise Pascal
“Se vuoi costruire una nave,
non radunare gli uomini
per fare loro raccogliere il legno,
e distribuire i compiti e suddividere il lavoro,
ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito”.
Antoine de Saint-Exupery
Hannah Arendt nasce nel 1906 da una famiglia ebrea tedesca molto benestante e non praticante. Anche se non riceve una educazione religiosa tradizionale, non negherà mai la propria identità ebraica, professando sempre (ma in modo niente affatto convenzionale) la propria fede in Dio. È proprio grazie a questa fede che Hannah Arendt si dedica per tutta la vita allo sforzo di comprendere il destino del popolo ebraico, identificandosi totalmente con le sue vicissitudini. Riguardo alle sue esperienze accademiche, sono fondamentali le città di Friburgo, Marburgo e Heidelberg, presso le cui sedi universitarie conosce Heidegger e Jaspers. Jaspers le trasmette un amore profondo per la libertà, mentre grazie ad Heidegger si sviluppa in lei una sconfinata venerazione per gli antichi greci e per il loro sforzo di convivere con gli aspetti tragici della vita. Redige la propria tesi di dottorato sul concetto di amore nel pensiero di Sant’Agostino, un testo difficile, che non lascia affatto prevedere la folgorante carriera della sua autrice. Lascia la Germania poco dopo l’ascesa al potere di Hitler, nel 1933. Si reca a Parigi, dove vive per otto anni impegnandosi a trovare famiglie disposte ad adottare gli orfani ebrei e i parenti di rifugiati. Dalle ricostruzioni bibliografiche più autorevoli risulta la sua esperienza di internamento, non in un campo di sterminio, ma in uno di concentramento (Forti A., 2005). Lascia la Francia e, all’incirca nel 1941, approda a New York, dove vive sino al sopraggiungere della fine, nel 1975. Più che americana, riceve da New York tutti gli stimoli per diventarne una fra le migliori interpreti.
Il fascino indiscusso di Hannah Arendt deriva dalla sua straordinaria abilità nell’interpretare i fenomeni morali, sociali, politici e culturali della propria epoca alla luce di una raffinatissima indagine filosofico-antropologica. Sia che si tratti di passioni umane come il peccato, la rabbia, la collera o di sentimenti, di istituzioni o ordinamenti politici, Hannah Arendt si presenta con una indagine originale. Nell’ambito dell’ all’intero XX secolo, nessun altro teorico della politica riesce, come invece nel caso della Arendt, ad unire una comprensione così profonda del male che può scaturire dall’attività politica, alla convinzione, altrettanto ferma e profonda, che la vita dedicata alla politica, qualora questa assuma la sua forma migliore, sia una delle più alte conquiste umane.
Il saggio, La condizione umana, scritto nel 1958, viene tradotto in italiano nel 1964. Oggi è considerato un classico del pensiero filosofico e politico del Novecento.
All’inizio degli anni sessanta la Arendt è decisamente già famosa per il suo discusso saggio sul totalitarismo, anche se il suo nome è legato all’inchiesta sul processo ad Eichmann, in cui l’autrice affronta alcuni aspetti controversi della storiografia sullo sterminio del popolo ebraico. Soprattutto la cosiddetta “soluzione finale” è analizzata nei suoi aspetti procedurali e burocratici. La Arendt mostra o presenta l’imputato del processo di Gerusalemme, il criminale di guerra Eichmann, nei panni di un ometto insignificante, una sorta di piccolo burocrate della macchina nazista. In realtà, l’autrice solleva la questione dell’interpretazione storica e politica del nazismo. In effetti, se gli ingranaggi dell’apparato di sterminio non erano costituiti da membri degeneri del ceto degli Junker, oppure da semplici avventurieri, bensì da uomini della strada, da tipici rappresentanti della società di massa, l’interpretazione storica del nazismo diventa più sociale e culturale, oltre che inquietante. Le analisi fin lì condotte non reggono più, perché troppo stereotipate. Non ci si può più basare sulla follia di Hitler per comprendere il fenomeno del nazismo, oppure sostenere una generica e quanto mai indimostrabile inclinazione al delitto del popolo tedesco.
Hannah Arednt elabora un teoria, peraltro già presente nell’opera sul totalitarismo, secondo la quale forme estreme e distruttive di dittatura, come il nazismo, sono in effetti in stretta relazione con la natura della società di massa, e che quindi, sempre secondo la sua prospettiva, possono risorgere. D’altra parte, nell’opera sul totalitarismo, la Arendt stabilisce una sorta di continuità culturale tra nazismo e stalinismo, specialmente riferendosi alle tecniche e alle pratiche del terrore, la segretezza degli apparati e l’invasione della sfera privata.
Nel suo saggio, Sulla rivoluzione, l’autrice sostiene la tesi che le rivoluzioni europee, e soprattutto quella francese, sono essenzialmente di tipo politico, proprio per il loro comune tentativo di costituire uno spazio condiviso in cui tutti gli uomini possano essere uguali. In sostanza, l’autrice ritiene che le rivoluzioni europee debbano essere considerate come un tentativo di domesticazione della sfera pubblica.
Nel saggio, La condizione umana, Hannah Arednt cerca una soluzione ai problemi posti dal totalitarismo e riformula il problema della libertà dell’agire, in antitesi agli idoli della società di massa. In opposizione al primato scientifico e cognitivo, come al primato del pensiero, cerca una diversa definizione dell’identità umana, trovandola nella rivalutazione dell’agire.
Il ruolo dell’agire nella condizione umana è un fatto evidente, ossia visibile intuitivamente. Esso è caratterizzato dalla pluralità, sia in riferimento alle diverse condizioni dell’umanità che in riferimento al mondo in cui l’uomo abita. La Arendt sostiene appunto che la pluralità è la legge della terra. La pluralità connota l’azione. Amare, pensare e creare sono facoltà possibili, in linea di principio, anche nell’isolamento. L’azione è impensabile senza la presenza di altri uomini, che interagiscono appunto fra loro. Occorre riconoscere dunque che l’agire non è una possibilità umana, bensì la conditio sine qua non della stessa nostra intera umanità.
Nelle diverse epoche, secondo la Arendt, si assiste ad una gerarchizzazione specifica delle facoltà umane. Nella cultura greca, al tempo di Platone ad esempio, l’azione assurge a rango supremo. Per la scuola socratica invece l’agire è subordinato alla contemplazione. Nella modernità, il primato del pensiero è sostituito con quello della conoscenza oggettiva. Infine, nella attuale condizione umana occidentale e post-moderna si assiste al trionfo di un tipo particolare di agire: il lavoro.
L’agire consente la realizzazione dell’identità umana, il rivelarsi di colui che agisce, l’apparire agli altri, il manifestarsi nella propria identità e differenza, anche all’interno di un elemento angosciante per l’umanità intera: l’imponderabilità. Secondo la Arendt, l’agire umano è caratterizzato dal reciproco gioco della parola, inteso come possibilità che i diversi esseri umani possano esprimersi sugli interessi comuni in uno spazio comune.
Gli assiomi della teoria politica di Hannah Arendt si riferiscono a tre condizioni fondamentali dell’esistenza umana:
· La prima condizione della nostra esistenza è l’ambiente naturale, organico ed inorganico, in cui vive l’uomo, la Terra. L’agire che corrisponde a tale condizione è il lavoro, con cui la specie umana assicura la propria sopravvivenza, ed il tipo umano corrispondente è l’animal laborans. L’attività lavorativa corrisponde allo sviluppo biologico del corpo umano, il cui accrescimento spontaneo, metabolismo e decadimento finale sono legati alle necessità presenti nel processo vitale dalla stessa attività lavorativa. La condizione umana di questa ultima è la vita stessa.
· La seconda condizione è o comprende l’insieme di artefatti di cui l’uomo si circonda per dare permanenza alla sua vita sulla terra. Questo insieme costituisce il Mondo Umano, a cui corrispondono l’agire dell’operare, e il tipo dell’homo faber. L’operare è l’attività che corrisponde alla dimensione non-naturale dell’esistenza umana, perché non è assorbita nel ciclo vitale sempre ricorrente della specie. Inoltre, quando essa si dissolve non è compensata dal ciclo vitale stesso. Il suo frutto è un mondo artificiale di cose, nettamente distinto dall’ambiente naturale. All’interno di questo mondo troviamo ogni vita individuale, mentre il significato stesso dell’operare consiste nel superamento e nel superamento di tali limiti. La condizione umana dell’operare è l’essere nel mondo.
· La terza condizione, difficile da definire, perché corrisponde ad una categoria oscurata e mistificata dall’evoluzione delle società occidentali, è ciò che i Greci definiscono polis, ovvero lo spazio pubblico in cui gli uomini possono entrare in relazione gli uni con gli altri, e conservare la memoria dei loro atti mediante il discorso. L’azione corrispondente è l’agire, nel senso della politeia, e il tipo umano attivo in questo spazio pubblico è quello che Aristotele definisce zoon politicon. L’azione è la sola attività che metta in relazione diretta gli uomini, senza la mediazione delle cose materiali. Nella polis la condizione umana vive nella pluralità, ossia nella consapevolezza che non l’Uomo ma gli uomini vivono sulla terra e abitano il mondo. Nonostante quasi tutti gli aspetti della nostra esistenza siano in qualche modo e misura legati alla politica, questa pluralità esistenziale non solo è la conditio sine qua non, ma la conditio per quam – di ogni vita politica. Nel linguaggio dei romani, forse il popolo più dedito all’attività politica che sia mai apparso in Occidente, le parole “essere” ed “essere tra gli uomini” (inter homines esse), e rispettivamente “morire” e “cessare di essere tra gli uomini” (inter homines esse desinere) sono sinonimi. Nella sua forma ancora più elementare, la condizione umana dell’azione è implicita anche nella Genesi: “Egli li creò maschio e femmina”. Qualora accettassimo questa versione della creazione del genere umano (e non quella secondo cui Dio originariamente creò solo l’Uomo), la moltitudine degli esseri umani è in effetti il risultato di una moltiplicazione. L’azione sarebbe un lusso superfluo, una capricciosa interferenza con le leggi generali del comportamento, se gli uomini fossero semplicemente illimitate ripetizioni riproducibili dello stesso modello. La pluralità è il presupposto dell’azione umana, proprio perché noi siamo tutti uguali, cioè tutti umani, ma in un modo tale che nessuno di noi sia mai identico ad alcun altro che visse, vive o vivrà.
Secondo Hannah Arendt, queste tre attività compongono la vita attiva, distinta dalla vita contemplativa, perché si svolge nell’interiorità dei soggetti e non comporta né attività esteriori né relazioni con gli altri uomini. Esercitare il potere significa “agire di concerto”, cioè agire secondo decisioni condivise e non secondo la logica della solitudine.
Tutte e tre le attività e le loro corrispondenti condizioni sono intimamente connesse con le condizioni più generali dell’esistere umano: nascita e morte, natalità e mortalità. L’attività lavorativa assicura tanto la sopravvivenza individuale quanto la vita della specie. L’operare e il suo prodotto, ossia l’artificio umano, conferiscono permanenza e continuità alla limitatezza della vita mortale e alla labilità del tempo umano. L’azione, in quanto fonda e conserva gli organismi politici, crea la condizione per il ricordo e la memoria, ossia la storia.
Lavoro, opera e azione sono anche radicati nella natalità, perché svolgono il compito di fornire e preservare il mondo per i nuovi venuti, che si presentano come stranieri. In questo modo, se ne prevede e valuta il costante afflusso.
Delle tre attività, è l’azione che è in più stretto rapporto con la condizione umana della natalità. In effetti, la nascita esprime l’inizio di un progetto (ut esset initium, homo creatus est, ci ricorda Tommaso d’Aquino), perché il nuovo venuto possiede la capacità di dar luogo a qualcosa di nuovo, cioè di agire. Alla luce di questo concetto di iniziativa, un elemento di azione, e perciò di natalità, è intrinseco in tutte le attività umane. Inoltre, poiché l’azione è l’attività politica per eccellenza, la natalità, e non la mortalità, può essere la categoria dominante o primaria o centrale del pensiero politico in quanto si distingue da quello meramente metafisico.
L’umanità è composta da individui che si influenzano reciprocamente e tale situazione diventa la condizione essenziale per l’esistere dell’intera umanità. Il mondo in cui si svolge la vita activa è quello delle cose prodotte dalle attività umane, e proprio queste cose, che devono la loro esistenza solo agli uomini, condizionano costantemente i loro artefici. Tutto quello che si pone in relazione continuativa e prolungata con la vita dell’uomo assume immediatamente il carattere di una condizione dell’intera esistenza umana.
Questa è la ragione fondamentale per cui gli uomini, qualsiasi cosa facciano, sono sempre esseri viventi condizionati. Qualunque elemento entri a far parte del mondo umano, per disposizione spontanea o per iniziativa dell’ingegno individuale, diviene parte della condizione umana. In sostanza, l’oggettività del mondo – ossia il suo carattere oggettivo o “di cosa” – e la condizione umana si integrano reciprocamente. Dunque, l’esistenza umana in quanto condizionata non sarebbe possibile senza le cose e queste, senza gli uomini, sarebbero un coacervo di enti privi di relazioni.
La condizione umana, si badi bene, non coincide affatto con la natura umana. Inoltre, la somma delle attività e delle capacità dell’uomo (che corrispondono alla condizione umana) non costituisce http:\\/\\/psicolab.neta di simile alla natura umana. Infatti, il più radicale mutamento nella condizione umana che noi possiamo immaginare sarebbe un’emigrazione dell’intera umanità dalla terra in un altro pianeta. Un evento del genere, non più del tutto impossibile oggi, comporterebbe per l’uomo il dover vivere in condizioni create dall’uomo stesso, radicalmente diverse da quelle che gli offre la terra. In tal caso, né l’attività lavorativa, né l’operare, né l’azione, e neppure il pensiero, cosi come crediamo di conoscerlo, avrebbero più alcun senso. Nonostante tutto ciò, anche questi ipotetici emigranti rimarrebbero umani, e la sola affermazione che potremmo fare circa la loro natura è che essi continuerebbero pur sempre ad essere condizionati, anche se in una situazione in buona parte autodeterminata.
Il problema della natura umana (quaestio mihi factus sum, come dice sant’Agostino) pare insolubile, sia nel suo significato psicologico individuale sia in quello filosofico generale. Nulla ci autorizza a ritenere che l’uomo abbia una natura-essenza affine a quella delle altre cose. In altre parole, se abbiamo una natura-essenza, soltanto un dio potrebbe conoscerla e definirla, e il primo requisito sarebbe che egli fosse in grado di parlare di un “chi” come se fosse in realtà un “che cosa”.
La difficoltà deriva dalle modalità della conoscenza umana, riferibili alle cose dotate di qualità naturali, come noi stessi. Queste strategia cognitive si rivelano sostanzialmente inadeguate quando ci chiediamo: “E chi siamo noi?” Per questo motivo, tutti i tentativi di definire la natura umana invariabilmente finiscono con l’introduzione di una divinità, oppure con il dio dei filosofi.
È ovvio che smascherare tali concetti filosofici del divino come concettualizzazioni di potenzialità e qualità umane non costituisce una dimostrazione, e neppure un argomento, della non-esistenza di Dio. Sta di fatto che i vari tentativi per definire la natura dell’uomo conducono facilmente ad un’idea che ci riporta ad un “super-umano”, che viene perciò identificata con il divino. Tutto ciò può destare dei dubbi sulla possibilità di un adeguato concetto di “natura umana”.
D’altra parte, le condizioni dell’esistenza umana (vita, natalità e mortalità, mondanità, pluralità e terra) non potranno mai spiegare che cosa noi siamo o rispondere alla domanda “chi siamo noi?” e per la semplice ragione che non ci condizionano in maniera assoluta. Oggi possiamo quasi dire di aver dimostrato anche scientificamente che, sebbene noi ora viviamo, e probabilmente vivremo per molto tempo ancora, soggetti come siamo alle condizioni della terra, non siamo meramente creature legate-alla-terra.
Questa ultima considerazione ci permette di introdurre un’ ulteriore riflessione che emerge come il fulcro del presente scritto, dove le puntualizzazioni teoriche della filosofia arendtiana trovano la loro ragione d’essere.
Si tratta della questione Educazione.
Tutti coloro che a qualunque titolo intervengono nel dibattito relativo alla Scuola ne sottolineano la crisi, sia di identità sia in riferimento alla funzione di agenzia educativa che da sempre esercita nella società Occidentale. Alcuni sostengono che la scuola deve radicalmente riformarsi, sotto la spinta delle forti mutazioni socio-culturali, come i nuovi mezzi di comunicazione, informatica, eclissi del libro, etc. Secondo questa posizione la scuola deve avvicinarsi agli interessi reali degli allievi. Altri sostengono invece che la rapida e caotica successione cui si sono avvicendate le riforme ha in realtà smantellato, peraltro con esiti devastanti, un quadro collaudato di formazione scolastica e di trasmissione del sapere. In questo scenario, si innesta peraltro la presenza di un periodo di basso investimento complessivo (politico, materiale e ideale) nella scuola, accompagnato, in chiave prettamente teorica, dall’ingresso delle scienze dell’educazione, in una misura mai vista in precedenza.
Su questi aspetti, con una lungimiranza impressionante, si esprime Hannah Arendt. Secondo la sua opinione vi è invitabile crisi dell’educazione quando siano in crisi, come accade oggi, due dei tre fattori su cui essa stessa si basa: la tradizione e l’autorità (il terzo è la libertà). In effetti, concordiamo con lei quando affermiamo che, contro la mentalità dominante, il vero problema dell’educazione si lega all’estrema difficoltà nella realizzazione di un livello minimo di conservazione, senza del quale è impensabile “educare” i giovani. La capacità (o l’incapacità) di educare costituisce il problema centrale di una società: “L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo dei giovani. Nell’educazione si decide anche se noi amiamo tanto i nostri figli da non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balia di se stessi, se li amiamo tanto da non strappargli di mano la loro occasione d’intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa d’imprevedibile per noi: e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti” (Arendt H., 2001:244).
Cosa ci dice la Arendt sugli aspetti che qui ci interessano? Influenzata dalla psicologia moderna e dai dogmi del pragmatismo, la pedagogia contemporanea si è trasformata in una scienza dell’insegnamento in genere, fino a diventare del tutto indipendente rispetto alla materia che di fatto s’insegna (Arendt H., idem). Il pragmatismo nel quale sembra caduta l’intera impalcatura educativa, promulgato come una nuova teoria dell’apprendimento, comporta, in termini tanto primitivi quanto ovvi, che l’imparare venga, per quanto possibile, sostituito dal fare. Poco valore si attribuisce alla padronanza della materia da parte del docente, mente ciò lo obbligherebbe invece a proseguire nell’attività di una crescita personale nel sapere. Sarebbe l’unico modo, l’apprendimento del docente, per non trasmettere le famigerate “morte nozioni”, proprio perché egli stesso si mostrerebbe agli allievi sempre teso al processo produttivo della conoscenza. L’intenzione consapevole non è d’insegnare una conoscenza, ma di trasmettere una tecnica.
Circa la responsabilità che, secondo la Arendt un vero docente dovrebbe assumersi davanti al giovane e nella relazione educativa si legge: “Poiché il bambino non conosce ancora il mondo, deve esservi introdotto un poco alla volta; e poiché è una cosa nuova, occorre far sì che egli giunga a maturità rispetto al mondo qual è” (Arendt H., ibidem:246). Di fronte all’allievo “l’insegnante si qualifica per conoscere il mondo e per essere in grado di istruire altri in proposito, mentre è autorevole in quanto, di quel mondo, si assume la responsabilità. Di fronte al ragazzo è una sorta di rappresentante di tutti i cittadini della terra che indica i particolari dicendo: ecco il nostro mondo” (Arendt H., ibidem:248).
Questa considerazione non può essere applicata in blocco a tutto il corpo docente della scuola italiana, anche se sono possibili due riflessioni in merito alla questione. In primo luogo, riteniamo che la posizione teorica della Arendt indichi esplicitamente di non consegnare alla pedagogia più di quanto le debba appartenere. Occorre a questo proposito vigilare che tale disciplina non si arroghi di decidere su questioni che non le spettano. Sarebbe opportuno evidenziarne i limiti e l’invadenza, quando ad esempio si pronunci in modo prescrittivo, là dove è doveroso invece riconoscere la pluralità e la libertà di posizioni disciplinari diverse. Non si dimentichi ad esempio che nella prospettiva più radicale della scuola pedagogica costruttivista si nega che l’introduzione alla realtà sia centrale nell’educazione, mentre tale scuola di pensiero si dedica allo studio dell’elaborazione del processo interno alla coscienza. In secondo luogo, si fa impellente che la formazione dei nuovi docenti privilegi gli aspetti collegati all’insegnamento della propria disciplina, con il tentativo di ridurre i tempi dell’esperienza personale. In sostanza, si dovrebbe fornire al docente contemporaneo, quello del terzo millennio della globalizzazione, indicazioni sugli strumenti didattici, considerandone gli aspetti educativi, assieme alla veneranda questione della valutazione.
Il mestiere di insegnate è importante soprattutto per il sapere che si trasferisce all’alunno, la cui attenzione alla società civile è direttamente proporzionale alla quantità di conoscenze che gli sono pedagogicamente comunicate. Diventa dunque decisiva in questo contesto l’autorevolezza dell’insegnate, cioè di colui che sa rendere interessanti i propri argomenti, perchè avere una buona preparazione significa non partire svantaggiati nella corsa al lavoro di domani. In ottica educativa, assumersi le proprie responsabilità significa esercitare la propria autorevolezza. L’educazione diventa dunque una azione conservatrice proprio per amore di quanto vi è di nuovo e sovversivo in un bambino, il quale custodisce la novità e la introduce come nuova in un mondo vecchio. Come sostiene la Arendt, l’educazione è il momento per decidere se amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo dalla rovina che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo di esseri nuovi, appunto i nostri giovani.